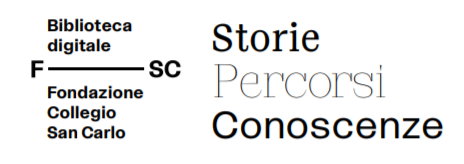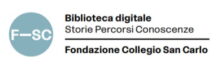Medicina e società
La storia della cura del corpo è in primo luogo storia di una conquista individuale, un approfondimento dell’autonomia […] ma è anche storia di un impegno collettivo”
Fino alle soglie dell’era moderna i pochi contributi riguardanti il nesso causale fra la situazione sociale, culturale, lavorativa e lo stato di salute delle persone che vi erano coinvolte erano determinati da domande parziali e interessate. Furono sottoposte ad indagine solo determinate “categorie di lavoratori” particolarmente vicine o di particolare interesse per coloro che finanziavano gli studi.
In parallelo, si sono sviluppate molte differenti “storie della medicina” se guardiamo allo sviluppo dell’arte e della scienza della cura dal punto di vista del suo rapporto con la società. Basti pensare a come, solo per rimanere al caso europeo, si siano sviluppate molte medicine differenti: le vicende delle cure tramandate dalla sapienza popolare, il più delle volte insegnata e appresa per via orale, ancora oggi in parte sopravvissuta e per molto tempo e per ampie fasce di popolazione l’unica possibile, costituiscono un caso emblematico.
Focus: scienza e società
1. Il corpo come luogo fisico
Il filosofo e medico arabo Avicenna scrisse un monumentale Canone della medicina nel quale riunì e ordinò sistematicamente le dottrine dei grandi padri della medicina antica, di Ippocrate e di Galeno, e le conoscenze aristoteliche. Concluso nel 1025 e tradotto in latino per la prima volta da Gherardo da Cremona prima del 1187, fu una pietra miliare della medicina medievale e contribuì non poco al mantenimento dei dogmi della medicina antica.
Questo Canone fu stampato a Milano nel 1473 e fu poi studiato nelle Università. Il medico Ferrari da Grado trasse spunto proprio da Avicenna per scrivere un libretto intitolato Expositiones super tractatum de urinis et vigesimam secundam fen tertii Canonis domini Avicennae, dedicato al duca Francesco Sforza, nel quale descrisse le principali malattie che colpivano gli uomini d’arme dello stesso duca.
- Le cure delle malattie dei soldati: il 22. Fen del Libro 3 del Canone della Medicina, 2013 – Nell’edizione del 2013 il testo di Avicenna, letto attraverso le parole di Ferrari da Grado, porta il lettore a gettare uno sguardo sugli ospedali medievali, sulle condizioni dello studio della medicina all’epoca e, sullo sfondo, a intravedere frammenti del dialogo fra cristiani e musulmani in area mediterranea.
Lentamente, con l’apertura degli studi ad una più attenta comprensione della localizzazione delle malattie in luoghi reali e individuabili del corpo, grazie anche agli studi anatomici di Andrea Vesalio, iniziò a farsi strada l’idea che il corpo fosse un luogo fisico governato da proprie leggi che hanno una logica interna. E’ questo luogo fisico ad interagire in modo naturale o, talvolta, in situazioni forzate e innaturali, con i fattori oggettivi esterni.
Questo passaggio, apparentemente lieve e tutto interno all’ambito della medicina, ebbe fin dalla fine del Cinquecento un risvolto denso di conseguenze anche sul piano giuridico: fra i fondatori delle diverse discipline mediche che dipesero direttamente da questo nuovo modo di percepire la realtà fisica della persona si può annoverare a pieno titolo Paolo Zacchia.
Nato a Roma nel 1584, ottenne una notevole fama grazie ad un’opera che pubblicò in nove volumi nell’arco di trent’anni, dal titolo Quaestionum medico-legalium. Il contenuto rispecchia esattamente il titolo: fu tra i riconosciuti padri fondatori della medicina legale. Avendo avuto anche una formazione giuridica, Zacchia ricorse ad un costante parallelismo fra medicina e ambito giuridico – l’opera si apre addirittura con due prefazioni, una dedicata ai medici e l’altra, a fronte, ai giuristi – e approfondisce un ventaglio notevole di aspetti fra i quali la tossicologia forense, la malattia mentale legata a determinati comportamenti criminali, e la malattia professionale.
2 . Le conquiste civili. La dignità della persona
Fin qui l’analisi del singolo. Fu tuttavia necessario attendere il Seicento, il “secolo della scienza”, per arrivare all’elaborazione di un nuovo sguardo sull’umanità nel suo complesso, acquisendo lentamente la consapevolezza della dignità di ogni persona e, di conseguenza, del diritto alla cura mirata e specifica, uno sguardo che nel corso del secolo si andrà ampliando sempre di più fino ad arrivare, nel Settecento, a diventare sistema con la trasformazione degli ospedali.
I ceti sociali meno abbienti furono lentamente compresi nello sguardo degli intellettuali, degli scienziati, degli artisti che li immortalarono nelle scene di genere prima come curiosità aneddotica e poi, sempre più, come oggetto di conoscenza. A partire da queste prime aperture saranno necessari altri secoli di elaborazione del concetto di uguaglianza e pari dignità della persona, i cui sviluppi sono ancora oggi al centro di dibattiti politici e ideologici.

3 . La nascita della medicina del lavoro
Torniamo alla questione dell’interazione del singolo con l’ambiente. I primi passi di questo percorso portarono a capire che possono essere le condizioni esterne a determinare lo stato di salute del singolo il quale può trovarsi, raramente per propria scelta, a dover fronteggiare realtà professionali che ne determinano il logoramento, fisico e psichico.
Fu compreso solo lentamente, nel corso del Seicento, quanto le situazioni di disagio o di vera e propria vessazione di molti lavoratori fossero frutto di privilegi non determinati dalla natura o da un ordine superiore ma da strutture sociali create e alimentate nel tempo, e quindi quanto su di esse si potesse in realtà intervenire. Divenne chiaro che se alcune malattie colpivano solo chi si trovava in determinate situazioni ciò significava che non ci si trovava di fronte ad una problematica legata alla singola persona ma era piuttosto la somma dei fattori esterni a determinare, talvolta in modo drammatico, le condizioni e la qualità di vita.
Quest’ultima sarà poi affrontata in modo sistematico da Bernardino Ramazzini, riconosciuto padre della medicina del lavoro come disciplina medica a sé stante.
Focus: “qualunque officina, anche la più umile”. Ramazzini e il lavoro
Bernardino Ramazzini (Carpi 1633 – Padova 1714) medico e scrittore, è considerato il padre della medicina del lavoro. Prima del suo studio sul campo, come si è visto sopra, nella letteratura medica esistevano solo osservazioni sporadiche. Il De morbis artificum diatriba è il primo testo sulle malattie occupazionali: in esso Ramazzini prese in considerazione sistematicamente le cause ambientali delle malattie, analizzando le sostanze manipolate dai lavoratori e le loro esalazioni, ma anche i movimenti e le posture mantenute durante l’attività e, una volta conosciuti i rischi associati alle diverse professionalità, affrontò il problema in ottica di prevenzione. Pionieristicamente, Ramazzini affermò la dignità tanto delle arti liberali quanto dei lavori più modesti e scrisse “Da parte mia ho fatto quanto ho potuto, né ho reputato indecoroso visitare personalmente ogni officina, anche la più umile”
Bernardino Ramazzini
In questa città [Modena…] c’è la consuetudine di pulire, ogni tre anni, le fogne […] Mentre si faceva questo lavoro in casa mia, mi resi conto che uno di questi vuotatori lavorava in quell’antro infernale con grande sveltezza. Mosso a compassione […] gli chiesi perché lavorasse con tanta fretta.
Il poveretto, alzando gli occhi da quell’antro e guardandomi, disse: Nessuno, se non lo prova, può immaginare cosa significhi stare in questo posto più di quattro ore; si rischia di diventar ciechi. Quando uscì dalla fogna esaminai attentamente i suoi occhi e vidi che erano molto arrossati e velati.
Allora gli chiesi come facessero i vuotatori di fogne a curarsi tali disturbi. Rispose: Ritornando subito a casa, come farò io ora; si chiudono in una camera buia e vi rimangono sino al giorno seguente lavandosi di quando in quando gli occhi con acqua tiepida; questo è il solo modo per trovare qualche sollievo.
Focus: la salute di chi siede scomodo
[p. 118] Lo star sedendo senza appoggio, egli è un modo un po’ incomodo di sedere, rispetto ad una più agiata sessione, ma nissuno dirà, che sia più faticoso del camminare… come appunto una trave, che sebben non possa drizzarsi senza l’impiego di una enorme potenza, quando è posta in piè, e sta a perpendicolo, … tutta la direzione del suo peso è parallela alla sua direzione perpendicolare; perché in questa posizione mantengasi, ricerca più attenzione che forza. [p. 37] Siccome la moderata fatica gli arti ingagliardisce e coroborra; la troppa gli snerva ed indebolisce… così una moderata meditazione solleva, risveglia, ed è di divertimento all’anima … un’eccessiva l’abbatte e mette in rovina.
Focus: la vecchiaia e i novecento anni dei Progenitori
Il trattato si presenta come un discorso medico sulle evidenze dell’età avanzata, volto alle osservazioni dei cambiamenti che avvengono nel corpo, ma non è esente da ingenuità che, a queste date, dovrebbero essere superate. Riconoscendo fra le cause una progressiva perdita di elasticità dei tessuti il medico osserva che la miglior condotta è la cura di sé fin dalla gioventù.
Domenico Antonio Mandini, La vecchiezza, 1800
Si accusa dalla comune opinione la bevanda del Caffè, come insidiosa alla robustezza muscolare, e perciò valevole a produrre il tremore in qualunque età, e quindi a sollecitarlo in vecchiezza, e a renderlo più gagliardo: io domanderei, perché non si dà questa colpa all’abuso del vino, e dei liquori forti. […]
Quanto sono mai da invidiarsi le annose età dei nostri Progenitori? Novecento e più anni di vita, e di vita probabilmente sana, giacché tale doveva stabilirla la frugale parsimonia di quei primi tempi, a quali erano ignote le stravaganze, li costumi, li eccessi…
4 . I “guaritori”
Fra i medici “anomali” del nostro Cinquecento si può annoverare anche Leonardo Fioravanti. Probabilmente non studiò mai medicina all’Università – non ci sono documenti a riguardo – ma imparò il mestiere girando per l’Italia e, sommando le esperienze di anni di lavoro, pubblicò nel 1564 il Compendio de i secreti rationali.
Curioso l’indice delle materie: si passa dai segreti della professione medica alla chirurgia, dall’alchimia ai belletti delle donne per finire con i misteri e i segreti più notevoli di varie arti ed esercizi.
- William Eamon, Il professore di segreti: mistero, medicina e alchimia nell’Italia del Rinascimento, Roma 2019
Focus: donne, streghe, erbe ed altri rimedi
Come spesso accade per l’antichità, le fonti a disposizione della riflessione storica sono parziali. Poco o nulla offre testimonianza della vita e della salute degli strati più umili della popolazione; tracce saltuarie della salute e delle malattie di artigiani e contadini sono offerte dagli scritti ippocratici Sulle epidemie. I pazienti di Galeno sono in genere nobili e altolocati e le loro storie offrono un spaccato molto selettivo delle condizioni di vita nella Roma imperiale.
Le altre fonti, da Celso a Sorano di Efeso, agli autori bizantini, molto di rado presentano casi clinici e storie individuali. Inoltre, abbiamo testimonianze scarse e frammentarie di qualsiasi sapere antico che sia un sapere “non dotto”, che si configuri cioè come una competenza pratica e che pertanto non sia trasmesso attraverso un processo di scrittura. […]
Tra le professionalità di margine va inclusa anche la competenza delle donne, sia quella attestata dall’associazione tra donne e phàrmaka, sia quella relativa alla sfera della nascita e della riproduzione, i cui passaggi salienti sono gestiti in modo pressoché esclusivo da maiai e obstetrices. L’analisi comparata di miti, iscrizioni funerarie, testi medici e letterari sia greci sia romani consente di ricostruire l’esistenza di un sapere femminile della medicina, i cui territori di competenza sono molto vicini a quelli della magia e della stregoneria.
- Barbara Ehrenreich, Le streghe siamo noi: il ruolo della medicina nella repressione della donna, 1975
- Silvia Vegetti Finzi, Streghe, levatrici, madri: il sapere delle donne, 2008
- Esther Cohen, Con il diavolo in corpo: filosofi e streghe nel Rinascimento, 2005
- Domizia Weber, Sanare e maleficiare: guaritrici, streghe e medicina a Modena nel 16° secolo, 2011
- Elena Brambilla, Corpi invasi e viaggi dell’anima: santità, possessione, esorcismo dalla teologia barocca alla medicina illuminista, 2010
- Adrienne Mayor, Il re veleno. Vita e leggenda di Mitridate, acerrimo nemico di Roma, 2010
5. Le riflessioni del Novecento
Nel corso del tempo l’acquisizione di consapevolezza del ruolo talvolta determinante dell’influenza esterna come fattore di rischio portò al riconoscimento delle malattie professionali come parte di una disciplina di protezione del lavoratore, anch’essa di lunghissima elaborazione e tuttora niente affatto scontata.
Nel corso del Novecento l’avanzare degli studi portò anche al riconoscimento di altre malattie legate alle condizioni sociali e, nello specifico, alle conseguenze di un regime alimentare povero di nutrienti: a base di castagne, nelle regioni appenniniche, ma soprattutto incentrato su polenta e pane di frumento. Da qui la pellagra, malattia insidiosa della pelle che poteva portare alla demenza e non di rado alla morte.
Su di essa si agitarono numerose voci che sostenevano, in particolare, l’origine batterica. Gli studi condotti a partire dal 1914 dal medico ungherese Joseph Goldberger dimostrarono che si trattava, invece, di carenza di vitamina B3, ma furono necessari molti anni e numerosi esperimenti, anche eticamente discutibili, finché nel 1937 fu riconosciuta la correttezza dell’intuizione di Goldberger.
Focus: il mais, la povertà e la pellagra
Pietro Costa Giani, Diario del Collegio, 1907, p. 239
25 febbraio 1907. Questa sera il Prof. Arturo Carraroli, insegnante Storia Naturale nelle scuole governative di Mantova, ha tenuto nella Sala Grande la sua lezione “sui tipi di pellagra e di pellagrosi” non offrendo una speciale volgarizzazione di idee ormai acquisite alla Scienza, ma svolgendo una teoria sua propria intorno all’origine e alle forme della pellagra, illustrandola con gran copia di argomenti e di ben riuscite proiezioni di tipi pellagrosi. Mentre la più grande parte dei dotti ritiene che questo terribile morbo sia originato da un intossicamento chimico e ne limita l’ampiezza a certe classi di popolazione rurale che si nutrono a preferenza di mais o di polenta, il prof. Carraroli, con tenacia d’apostolo e con convinzione di ricercatore coscienzioso, sostiene che la causa della pellagra consiste soltanto in un germe parassitario, che egli è riuscito ad isolare e a studiare minutamente (che era ammirato dal pubblico in parecchie e belle proiezioni fatte su preparati fotomicroscopici) e che tal malattia si allarga anche alle classi più agiate e meglio nutrite, prendendo forme diverse, spesso identificate falsamente con altre malattie. L’intera conferenza del chiarissimo professore si è aggirata intorno a questo punto essenziale, su cui i dotti non si trovano d’accordo. Il Carraroli bene lumeggiò il grave problema anche sotto l’aspetto sociale ed umano, dimostrando come da molti anni questa materia assorba l’attività del conferenziere, al quale il numeroso pubblico intervenuto gli fu largo di caldi e sinceri applausi.
000
Focus: discriminazioni e sanità pubblica
"...Maccacaro non era soltanto un uomo di scienza, ma era uno studioso che da anni lottava contro i difetti, le storture, le ingiustizie della medicina italiana, esponendosi sempre in prima persona. Insegnava che morte e malattie discriminano tra ricchi e poveri, tra capitale e lavoro, che la medicina è ancora classista. ...Di solito i ricercatori compiono indagini, ma poi le pubblicano su riviste specializzate. Maccacaro, invece, socializzava i risultati, voleva che se ne discutesse nei Consigli di fabbrica, in quelli di zona. Non voleva che quanto emerge dalle indagini di statistica medica finisse in un cassetto a disposizione di pochi.". Dal “CORRIERE DELLA SERA” del 27 gennaio 1977
000
000
Focus: il controllo sociale del corpo
000
0
000
- Gilberto Corbellini, Scienza e politica: il ruolo della ricerca scientifica nei sistemi democratici, 2017
- Gilberto Corbellini, Scienza, quindi democrazia, 2021
- Bernardino Ramazzini, Epistolario, 1964
- Maria Serena Mazzi, Salute e società nel Medioevo, 1978